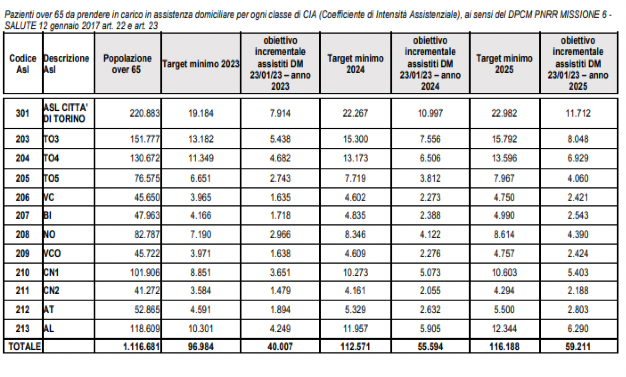È un errore focalizzarsi su logiche di contenimento della spesa in sanità senza preoccuparsi di capire se l’utilizzo della spesa produca esiti “veri” sulla salute
Conviviamo da anni, con grande difficoltà, in un contesto di vincoli di spesa pubblica in diversi ambiti del mondo sanitario: quello sui dispositivi medici (la legge sui pay-back), quello sulle risorse umane, che prima mordeva sul lato della domanda di posti di lavoro (la normativa imponeva la riduzione del costo del personale sul tetto del 2004) e che ora agisce pesantemente su quello della disponibilità di professionisti, quello sui farmaci più costosi – ricordo i tetti sul file F e doppio canale –, solo per citarne alcuni tra i più noti; ma potremmo estendere il discorso anche ai vincoli di spesa pubblica dettati dalla normativa europea sul debito e sul deficit dello Stato.
Fino ad ora, sbagliando, ci siamo focalizzati su logiche di contenimento della spesa o su richieste di aumento dei tetti di spesa, ma non ci siamo preoccupati di capire, con la necessaria determinazione e metodo, se, a parità di spesa, gli attuali meccanismi di ripartizione ed utilizzo della spesa siano corretti e producano efficaci esiti di salute.
È puro buon senso capire che quando ci sono vincoli e restrizioni bisogna utilizzare bene ciò che si ha. Stiamo spendendo bene i soldi che abbiamo e stiamo generando esiti di salute utili per i nostri cittadini? Rispondere a queste domande è il compito di chi fa programmazione sanitaria a livello nazionale e regionale e di chi dirige strutture in sanità.
Ad altro livello si gioca poi la partita dell’aumento delle risorse, che se è portata avanti come mera richiesta di incremento di spesa sanitaria a scapito di altre necessità di bilancio dello Stato può risultare demagogica, perché se l’aumento di spesa pubblica non è finanziato dalla produzione di valore, va ad incidere su parametri di equilibrio di finanza pubblica non modificabili al momento e che poi generano altri pesanti impatti.
Utile invece, per chi si occupa a livello programmatorio di sanità, è ragionare su un diverso paradigma di erogazione sanitaria che misuri le cosiddette eccellenze (termine abusato) in termini di esiti di salute per i cittadini (outcome) e distribuisca le risorse anche in funzione di queste capacità, sia tra le diverse regioni sia all’interno delle regioni. Favorire quindi l’identificazione della qualità e poi agire in maniera conseguente.
Questo tema è in parte presente nei meccanismi di distribuzione del Fondo sanitario nazionale per la quota destinata al raggiungimento dei cosiddetti LEA e del nuovo sistema NSG per il monitoraggio dell’appropriatezza sanitaria. Sono infatti predisposti diversi (un po’ troppi) indicatori che vanno a valutare la capacità delle regioni di generare un risultato di salute per i propri cittadini in diverse aree (prevenzione, ospedaliera, territoriale). È un buon passo in avanti, si può discutere sulla proporzione della quota legata alla capacità di fare salute rispetto a quella capitaria, ma risulta ancora disancorato dal secondo passaggio, ovvero quello tra le regioni e le singole strutture sanitarie regionali.
Bisogna attentamente considerare la prospettiva entro la quale sono posti i LEA. La loro completa erogazione è garanzia di qualità delle cure? Certamente no. Universalismo e solidarismo sono un “valore costitutivo ex-ante”, statuito dalla legge 833/78, oppure essi rappresentano la logica di valori guida per il raggiungimento del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione? Certamente sì. Ma universalismo significa che tutti possano avere accesso alle cure (complessivamente intese) che producono valore per la salute, che almeno la conservino in buono stato quando non la migliorino. Cioè: le cure devono avere un obiettivo e il suo raggiungimento deve essere misurato, ne deve essere determinato il valore per la persona e la collettività, incluso quanto attiene agli aspetti sociali ed economici. Deve essere disponibile quello che genera valore per tutti coloro che ne hanno bisogno, non quello che tutti “ritengono utile” o dovuto, come veicolato impropriamente da certa politica demagogica, dai social, dall’infodemia e così via.
Il solidarismo, come è noto ma spesso dimenticato, implica una corresponsabilità solidale nell’uso di risorse pubbliche, quindi comuni. Se è uso di qualcosa o di qualcuno, in una situazione di risorse definite, limito la possibilità di accesso ad altri, che magari hanno più bisogno di me. Ma, come accaduto nel secondo dopoguerra, è necessaria una coscienza civica dettata dalla necessità di fare ciascuno la propria parte per ricostruire, contribuendo e facendo delle scelte di priorità ed individuando ciò che è essenziale.
Cosa succede quando le regioni distribuiscono questi soldi alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate? Seguono dei principi di misurazione della generazione di risultati di salute? Li misurano? E se sì, che utilizzo ne fanno?
Le singole regioni sono capaci di valutare la qualità dell’erogazione sanitaria delle proprie strutture in maniera oggettivabile? E se sì, cosa ne fanno in termini di razionale utilizzo di questi dati per la programmazione sanitaria? Quali strumenti di governance hanno a disposizione per evitare di fare scelte su chi ha responsabilità di programmazione sanitaria e di erogazione sanitaria non influenzate solo dalle scelte politica ma dai risultati di salute per i cittadini?
Su questo riteniamo ci siano ampi spazi di miglioramento su almeno due fronti. Il sistema degli indicatori non manca, ma non è efficace il processo di gestione degli obiettivi e di valutazione per le strutture sanitarie di questi indicatori. Non ci soffermiamo sulle motivazioni perché ampiamente descritte in un recente post.
Il secondo fronte è invece legato al tema degli utilizzi, in termini di governance, di questi indicatori per finalità di programmazione sanitaria. Difficilmente infatti vengono utilmente applicati per scelte di programmazione ed erogazione sanitaria. Ci si limita al momento, e con grande ritardo rispetto a quando vengono calati sulle singole strutture sanitarie, ad osservarne i valori per poi definire punteggi e valutazioni economiche dei risultati per le direzioni.
Ma se alcuni indicatori esprimono ad esempio forte criticità nell’ambito delle percentuali di volume minime per eseguire in sicurezza operazioni chirurgiche o parti, se si presentano numeri di eccessivi accessi inappropriati al pronto soccorso, numeri di ri-ospedalizzazione frequente di pazienti cronici, percentuali di morti post intervento superiori agli standard nazionali, che riflessioni si fanno dal punto di vista della modifica dell’erogazione sanitaria per il bene dei pazienti?
Le più frequenti risposte e, crediamo, le meno efficaci dal punto di vista del paziente sono quelle legate all’aumento richiesto di volume di offerta. Strategia inefficace intanto perché si scontra con i limiti di cui abbiamo parlato in altra sede (quello delle risorse umane e tecnologiche) e quello della generazione di falsa domanda di prestazioni. Chi ha detto poi che fare più prestazioni equivalga a soddisfare il bisogno di salute? Bisogna vedere se alla fine il paziente starà meglio e se aveva bisogno di quelle prestazioni.
Bisognerebbe invece sviluppare metodi di ragionata ridistribuzione dell’offerta sanitaria ed anche dei budget economici in funzione della capacità di erogare risultati di salute e non solo quantità di prestazioni. Questo vuol dire avere il coraggio di fare delle scelte di razionalizzazione di strutture inefficaci in termini di outcome clinico a vantaggio della salute dei pazienti. Diversamente si polverizzano risorse a danno degli stessi. Un primo esempio di questa logica è stata la DGR di riduzione del valore riconosciuto alle ASST lombarde sui rimborsi dei ricoveri oncologici e non oncologici in relazione al mancato raggiungimento dei tempi di attesa, applicato nel 2022. Senza fare delle scelte di programmazione sanitaria, coraggiose e legate a misurazioni, si è destinati ad una lenta decadenza che purtroppo è evidente.
Un’ altra derivata di questo ragionamento di riallocazione ed allocazione efficiente delle risorse è il riconoscimento dell’importanza della multidisciplinarietà in sanità. Altro termine abusato, al pari di “eccellenza”, ma a fronte del quale non sono scattati meccanismi di carattere sistemico sulla sua realizzazione pratica, al di là di quelli relativi ai PDTA clinici (percorsi diagnostico terapeutici).
Se abbiamo capito che l’erogazione sanitaria è legata ad una interazione strutturata e disciplinata tra operatori della salute, perché non si è fatto niente per cambiare un sistema di remunerazione delle prestazioni che è la negazione di questo corretto principio? Abbiamo da un lato obiettivi sugli outcome clinici che si basano su processi multidisciplinari e dall’altro si pagano gli ospedali in base a singole prestazioni che sono la negazione di questi percorsi.
L’attuale meccanismo di remunerazione delle aziende sanitarie è infatti ancora legato al modello del DRG, o del rimborso della tariffa ambulatoriale ovvero della singola prestazione, e non valuta in alcun modo la multidisciplinarietà di molte delle moderne prestazioni sanitarie. Quindi si riconosce il valore clinico di lavorare in squadra, ma poi si lascia in piedi un modello di remunerazione che non le valuta. Il risultato è disaccoppiare qualità clinica ed equilibrio economico con potenziali ripercussioni sulla salute dei cittadini.
Se sappiamo cosa va fatto per garantire la presa in carico e la cura di un paziente con scompenso cardiaco o di una paziente con carcinoma mammario (breast unit), che deve vedere l’integrazione tra équipe di diversi reparti dell’ospedale, o della struttura territoriale (penso al follow up post evento acuto dei medici di medicina generale e degli infermieri di famiglia o alla presa in carico dei cronici), che senso ha riconoscere singole prestazioni tra loro slegate e che non identificano l’esito clinico per il paziente?
Senza considerare che solo attraverso una diversa modalità di lavoro riusciremo a far fronte alla carenza quantitativa del numero delle risorse sanitarie. Quelle che ci sono devono lavorare in maniera diversa, integrata ed il loro valore per la salute dei pazienti deve essere misurato ed anche remunerato di conseguenza.
Bisogna passare da una remunerazione a prestazione ad una remunerazione al cosiddetto budget di salute.
Va pertanto definito l’insieme di prestazioni necessarie per quella patologia e misurato l’effetto di salute sul paziente identificando ed allocando un budget di salute che ricomprenda insiemi strutturati di esami e prestazioni. Tale percorso, oltre a generare esiti clinici, ridurrà l’inappropriatezza e la cosiddetta medicina difensiva. La responsabilità di un direttore deve poi misurarsi con questi insiemi logici di disponibilità di spesa e di risultati clinici da raggiungere. Ragionare solo sugli uni o sugli altri è sbagliato. Come diceva Michael Porter, valore in sanità è outcome for dollar spent (risultato clinico per ogni dollaro speso).
Questo approccio, applicato ad esempio anche ai pazienti cronici, potrebbe portare a ripensare il modello di remunerazione anche dei medici di medicina generale, troppo ancorato anche questo a modelli capitari per favorire l’integrazione con gli infermieri di famiglia e generando così risparmi per il sistema sanitario in termini di riduzione degli effetti acuti sul paziente che in parte possono essere anche redistribuiti all’équipe, come dimostrato da alcune sperimentazioni sul tema.
Non si può migliorare ciò che non si misura, ma dopo bisogna avere il coraggio, anche politico, di cambiare scelte di allocazione su strutture, risorse economiche, tecnologiche ed anche direttori.